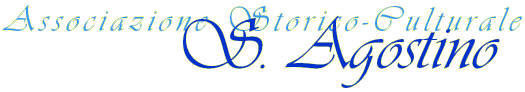Contenuto
Percorso : HOME > Africa agostiniana > Africa romana > TripolitaniaAfrica romana: La Tripolitania

Mosaico del pavimento della basilica cristiana di Sabratha
LA TRIPOLITANIA
A Sabratha, la più occidentale delle tre città libiche, faceva capo, dopo aver superato le dune di sabbia, la strada romana costiera di Nerva. Questa città era la meta di una delle grandi strade carovaniere dell'Africa centrale che, attraversate le oasi ai piedi del ripido gebel alle spalle di Sabratha, arrivava a Gadames costeggiando le alture rocciose di Al Hammadah al Hamra. Situata nel punto dove confinano oggi la Tunisia, l'Algeria e la Libia, Gadames (la Cydamae romana) - destinata a diventare una delle fortezze-chiave dei limites africani - era stata anni addietro uno degli entrepots delle quattro grandi strade commerciali: quello da cui attraversando il Sahara si arrivava al Lago Chad e di qui al Niger e all'Africa Centrale superando una distanza totale di più di duemila miglia.
A Sabratha si riversavano le ricchezze dell'Africa centrale: polvere d'oro, avorio, piume di struzzo, materie coloranti, pelli e soprattutto belve per rifornire i circhi romani di tutto il mondo. Che questa città fosse lo sbocco principale del commercio africano è dimostrato dal simbolo della sua attività: l'elefante del pavimento in mosaico del Piazzale delle Corporazioni di Ostia. Dopo la caduta di Cartagine, Sabratha, prolungata fino a farla arrivare al mare, diventò a poco a poco romana.
La strada costiera si trasforma, entrandovi, nel suo decumanus, che si prolunga ad est e a ovest lungo la costa. Più lontano si trovavano i Bagni di Oceano e il Tempio di lside. Il teatro, che si stagliava sullo sfondo del Mediterraneo, era l'orgoglio di questa città. Il suo palcoscenico ha un pavimento in mosaico; il podium è decorato con bassorilievi rappresentanti divinità e figure allegoriche. Il teatro vero e proprio è augusteo, ma il palcoscenico risale al tempo degli Antonini. Sabratha (che alcuni preferiscono chiamare Ola) fu anche, nell'anno 157, la sede del famoso processo per stregoneria contro l'autore dell'Asinus aureus. Nato a Madauros, un piccolo villaggio agricolo della Numidia, Lucio Apuleio, ereditati due milioni di sesterzi, aveva studiato a Cartagine e ad Atene. Rimasto al verde dopo i Giuochi Olimpici, si era ridotto a vivere di espedienti.
Si fece iniziare al culto di lside e partì per Roma, dove si perfezionò in latino e oratoria ed ebbe successo come avvocato. Mentre se ne tornava a casa in Numidia fece una visita a un suo vecchio compagno di studi Sinicio Ponziano. Prolungando poi il suo soggiorno nella lussuosa Sabratha si legò, malgrado la differenza di età, con un'amica di sua madre, Pudentilla, sofferente di disturbi nervosi, provocati, affermava il suo medico, da quattordici anni di vedovanza, e da cui avrebbe potuto guarire soltanto prendendosi un marito più giovane di lei. I due erano sposati da poco quando, dopo aver intestato ad Apuleio tutti i suoi beni, Pudentilla perdette il figlio.
E poiché molti avevano letto le Metamorfosi di Lucio Apuleio, i parenti della vedova accusarono suo marito di averne conquistato l'affetto con arti magiche. Per nostra fortuna ci è giunta l'arringa, di un caustico umorismo, che Apuleio tenne in sua difesa davanti al governatore della provincia, Claudio Massimo, riuscendo a farsi assolvere «Vi ho dunque spiegato, miei signori, perché secondo me fra stregoni e pesci non c'è assolutamente nulla in comune ...». Tripoli, che dista sessantacinque chilometri (quaranta miglia) da Sabratha, la più grande delle città che formavano la tripolis, disponeva di un grande porto naturale ed era fornita di abbondante acqua sorgiva, di un fertilissimo hinterland e di uliveti sconfinati.
Vi si produceva tanto olio che Giulio Cesare poté esigerne dai Tripolini, per punirli di aver sostenuto i suoi nemici, un contributo annuo di un milione di misure. Oggi Tripoli non vanta più niente di romano, all'infuori dell'Arco Trionfale, una volta splendido, eretto nell'anno 163, in onore di Marc'Aurelio e Lucio Vero, e sotto cui passava la Via di Nerva. Leptis Magna, la terza città della tripolis, senz'altro la più importante dell'intera costa mediterranea fra Cartagine e Alessandria, è famosa per la sua storia, i suoi monumenti e la sua gastronomia. «La città di Leptis», scrisse Sallustio, «fu fondata dai Tirii, che si dice vi si siano rifugiati dal mare (nell'ottavo secolo a.C.) per sfuggire ai disordini civili del Libano.»
Leptis è situata tra le Sirti, due baie sconfinate quasi all'estremo est del Nordafrica. I Fenici vi stabilirono la loro prima colonia commerciale in un porticciuolo formato, sboccando in mare, dall'Uadi Lebda. Vi si smerciavano soprattutto olio d'oliva, avorio e schiavi, ai quali fu presto aggiunta l'erba silphium, nota altrove come «concime del diavolo», o assafetida (sconosciuta oggi come pianta) e largamente usata dai Romani nella loro cucina. Nella sua Historia Naturalis Plinio il Vecchio dedica al silphium un intero capitolo. Leptis Magna faceva parte da pochi anni della nuova provincia romana dell'Africa fondata nel 23 a.C., quando un certo Calpurnio Pisone cominciò a restaurare i suoi vecchi quartieri e a costruirne di nuovi. Nel primo anno dell'era cristiana il suo teatro era lussuoso quasi quanto quello di Sabratha. Nuovi fori vennero eretti sui vecchi e ricchissimi bagni pubblici e privati costruiti appena venivano trovate le sorgenti per alimentarli. Solo sei anni dopo, nell'anno 17, Leptis Magna costruì la sua prima strada romana interna. Durante gli scavi eseguiti in quella zona gli archeologi italiani hanno scoperto un cippo, alto quasi due metri e del diametro di quarantaquattro centimetri, su cui si legge che sotto l'imperatore Tiberio un certo Elio Lamia costruì nell'anno 15 quarantaquattro miglia di strada nell'arido deserto dell'interno.
I miliaria di questa Via Lamia risalgono invece al regno di Caracalla. La nuova strada permise di distruggere completamente la fauna selvaggia e di respingere le tribù del deserto. La regione poté svilupparsi e i coltivatori prolungare verso l'interno i loro uliveti. Le tribù del deserto non attesero molto per ribellarsi a questa nuova usurpazione dei Romani. Al tempo del suo dominio Cartagine non aveva mai cercato di modificare i loro costumi e il ritmo delle loro attività. Le tribù si spingevano ogni anno fino alla costa per far ingrassare i loro buoi e i loro cavalli, e dopo essersi ritirate nelle oasi per il raccolto dei datteri tornavano infine nel deserto. Private dei loro pascoli cominciarono ad assalire e a saccheggiare le nuove colonie.

Resti del teatro di Sabratha
Non bisogna dimenticare che i Garamanti erano considerati signori del deserto, anche se poco conosciuti perfino nel V secolo a. C., al tempo di Erodoto. «Più addentro, a sud», scrisse il famoso storico, «in quella parte della Libia dove si trovano le bestie feroci, vivono i Garamanti ... una tribù molto numerosa che copre di terra le saline per poterle coltivare. Questi Garamanti inseguono gli Etiopi con carri a quattro cavalli ...».
A Sabratha, la più occidentale delle tre città libiche, faceva capo, dopo aver superato le dune di sabbia, la strada romana costiera di Nerva. Questa città era la meta di una delle grandi strade carovaniere dell'Africa centrale che, attraversate le oasi ai piedi del ripido gebel alle spalle di Sabratha, arrivava a Gadames costeggiando le alture rocciose di Al Hammadah al Hamra. Situata nel punto dove confinano oggi la Tunisia, l'Algeria e la Libia, Gadames (la Cydamae romana) - destinata a diventare una delle fortezze-chiave dei limites africani - era stata anni addietro uno degli entrepots delle quattro grandi strade commerciali: quello da cui attraversando il Sahara si arrivava al Lago Chad e di qui al Niger e all'Africa Centrale superando una distanza totale di più di duemila miglia. A Sabratha si riversavano le ricchezze dell'Africa centrale: polvere d'oro, avorio, piume di struzzo, materie coloranti, pelli e soprattutto belve per rifornire i circhi romani di tutto il mondo.
Che questa città fosse lo sbocco principale del commercio africano è dimostrato dal simbolo della sua attività: l'elefante del pavimento in mosaico del Piazzale delle Corporazioni di Ostia. Dopo la caduta di Cartagine, Sabratha, prolungata fino a farla arrivare al mare, diventò a poco a poco romana. La strada costiera si trasforma, entrandovi, nel suo decumanus, che si prolunga ad est e a ovest lungo la costa. Più lontano si trovavano i Bagni di Oceano e il Tempio di lside. Il teatro, che si stagliava sullo sfondo del Mediterraneo, era l'orgoglio di questa città. Il suo palcoscenico ha un pavimento in mosaico; il podium è decorato con bassorilievi rappresentanti divinità e figure allegoriche.
Il teatro vero e proprio è augusteo, ma il palcoscenico risale al tempo degli Antonini. Sabratha (che alcuni preferiscono chiamare Ola) fu anche, nell'anno 157, la sede del famoso processo per stregoneria contro l'autore dell'Asinus aureus. Nato a Madauros, un piccolo villaggio agricolo della Numidia, Lucio Apuleio, ereditati due milioni di sesterzi, aveva studiato a Cartagine e ad Atene. Rimasto al verde dopo i Giuochi Olimpici, si era ridotto a vivere di espedienti. Si fece iniziare al culto di lside e partì per Roma, dove si perfezionò in latino e oratoria ed ebbe successo come avvocato.
Mentre se ne tornava a casa in Numidia fece una visita a un suo vecchio compagno di studi Sinicio Ponziano. Prolungando poi il suo soggiorno nella lussuosa Sabratha si legò, malgrado la differenza di età, con un'amica di sua madre, Pudentilla, sofferente di disturbi nervosi, provocati, affermava il suo medico, da quattordici anni di vedovanza, e da cui avrebbe potuto guarire soltanto prendendosi un marito più giovane di lei. I due erano sposati da poco quando, dopo aver intestato ad Apuleio tutti i suoi beni, Pudentilla perdette il figlio. E poiché molti avevano letto le Metamorfosi di Lucio Apuleio, i parenti della vedova accusarono suo marito di averne conquistato l'affetto con arti magiche. Per nostra fortuna ci è giunta l'arringa, di un caustico umorismo, che Apuleio tenne in sua difesa davanti al governatore della provincia, Claudio Massimo, riuscendo a farsi assolvere «Vi ho dunque spiegato, miei signori, perché secondo me fra stregoni e pesci non c'è assolutamente nulla in comune ...».
Tripoli, che dista sessantacinque chilometri (quaranta miglia) da Sabratha, la più grande delle città che formavano la tripolis, disponeva di un grande porto naturale ed era fornita di abbondante acqua sorgiva, di un fertilissimo hinterland e di uliveti sconfinati. Vi si produceva tanto olio che Giulio Cesare poté esigerne dai Tripolini, per punirli di aver sostenuto i suoi nemici, un contributo annuo di un milione di misure. Oggi Tripoli non vanta più niente di romano, all'infuori dell'Arco Trionfale, una volta splendido, eretto nell'anno 163, in onore di Marc'Aurelio e Lucio Vero, e sotto cui passava la Via di Nerva. Leptis Magna, la terza città della tripolis, senz'altro la più importante dell'intera costa mediterranea fra Cartagine e Alessandria, è famosa per la sua storia, i suoi monumenti e la sua gastronomia. «La città di Leptis», scrisse Sallustio, «fu fondata dai Tirii, che si dice vi si siano rifugiati dal mare (nell'ottavo secolo a.C.) per sfuggire ai disordini civili del Libano.»

L'arco dell'imperatore Settimio Severo a Leptis Magna
Leptis è situata tra le Sirti, due baie sconfinate quasi all'estremo est del Nordafrica. I Fenici vi stabilirono la loro prima colonia commerciale in un porticciuolo formato, sboccando in mare, dall'Uadi Lebda. Vi si smerciavano soprattutto olio d'oliva, avorio e schiavi, ai quali fu presto aggiunta l'erba silphium, nota altrove come «concime del diavolo», o assafetida (sconosciuta oggi come pianta) e largamente usata dai Romani nella loro cucina. Nella sua Historia Naturalis Plinio il Vecchio dedica al silphium un intero capitolo. Leptis Magna faceva parte da pochi anni della nuova provincia romana dell'Africa fondata nel 23 a.C., quando un certo Calpurnio Pisone cominciò a restaurare i suoi vecchi quartieri e a costruirne di nuovi.
Nel primo anno dell'era cristiana il suo teatro era lussuoso quasi quanto quello di Sabratha. Nuovi fori vennero eretti sui vecchi e ricchissimi bagni pubblici e privati costruiti appena venivano trovate le sorgenti per alimentarli. Solo sei anni dopo, nell'anno 17, Leptis Magna costruì la sua prima strada romana interna. Durante gli scavi eseguiti in quella zona gli archeologi italiani hanno scoperto un cippo, alto quasi due metri e del diametro di quarantaquattro centimetri, su cui si legge che sotto l'imperatore Tiberio un certo Elio Lamia costruì nell'anno 15 quarantaquattro miglia di strada nell'arido deserto dell'interno. I miliaria di questa Via Lamia risalgono invece al regno di Caracalla. La nuova strada permise di distruggere completamente la fauna selvaggia e di respingere le tribù del deserto. La regione poté svilupparsi e i coltivatori prolungare verso l'interno i loro uliveti. Le tribù del deserto non attesero molto per ribellarsi a questa nuova usurpazione dei Romani. Al tempo del suo dominio Cartagine non aveva mai cercato di modificare i loro costumi e il ritmo delle loro attività. Le tribù si spingevano ogni anno fino alla costa per far ingrassare i loro buoi e i loro cavalli, e dopo essersi ritirate nelle oasi per il raccolto dei datteri tornavano infine nel deserto. Private dei loro pascoli cominciarono ad assalire e a saccheggiare le nuove colonie.
Non bisogna dimenticare che i Garamanti erano considerati signori del deserto, anche se poco conosciuti perfino nel v secolo a. C., al tempo di Erodoto. «Più addentro, a sud», scrisse il famoso storico, «in quella parte della Libia dove si trovano le bestie feroci, vivono i Garamanti ... una tribù molto numerosa che copre di terra le saline per poterle coltivare. Questi Garamanti inseguono gli Etiopi con carri a quattro cavalli ...». Guidata da Cornelio Balbo, la III Legione Augusta si decise infine a marciare contro quella tribù turbolenta. Balbo era il nipote di quel Cornelio Balbo di Cadice senza il quale Giulio Cesare non sarebbe forse riuscito a trionfare in Spagna. Duro e implacabile come suo zio, fece percorrere perfino nel deserto alle sue legioni più di venti miglia al giorno; insegui i Garamanti oltre Ghadames - dove occupò un avamposto - e attraversò l'altopiano pauroso di Al Hammadah fino alla loro oasi di Brak e oltre il caravanserraglio di Sebha. Nell'anno 69, sotto la guida dei Garamanti le tribù del deserto arrivarono di nuovo davanti a Leptis Magna. L'assedio fu spezzato soltanto dall'arrivo di coorti della III Legione Augusta comandate da Valerio Festo. Carichi di bottino i Garamanti stavano riprendendo la loro via tradizionale nel deserto quando, avendone trovata una più breve di quattro giorni (che i Romani chiamarono poi la Praeter Caput Saxi) Valerio Festo li accerchiò e dopo averli sterminati se ne tornò indietro col bottino.
Sembra che più tardi, sotto Traiano, i Romani siano venuti a patti con i Garamanti. Nell'anno 100 due loro comandanti, Settimio FIacco e Giulio Materno, arrivarono in Etiopia attraversando con marce forzate in trenta giorni il deserto del Sahara e il Sudan. Aiutati dai Garamanti catturarono un gran numero di Etiopi assaltandoli con i carri a quattro cavalli dei loro alleati.
I racconti di carri a quattro cavalli nel Sahara hanno lasciato increduli per secoli gli storici. Com'era possibile che questi Garamanti, un popolo neolitico che usava come strumento soltanto accette di pietra, avessero potuto costruire un congegno complicato come la ruota a sei raggi? Soltanto in epoche molto recenti gli esploratori hanno trovato nel deserto la prova che Erodoto aveva ragione. Il paleontologo francese Henri Lhothe, che in venticinque anni di esplorazioni rinvenne nei canyons del Sahara francese le pitture di Tassili, ha scoperto centinaia di disegni preistorici di carri tirati da cavalli, raffigurati quasi sempre mentre inseguono uomini o animali. Negli affreschi dei Tassili uomini e animali sono ritratti come vivevano fra 6000 anni a.C. e i nostri tempi. Anche nel Tradart Acacus, dove, cinquecento miglia ad est, il Tropico del Cancro taglia la Libia, il Niger, il Ciad e l'Algeria, sono stati rinvenuti affreschi con gli stessi carri tirati da cavalli, ma riprodotti con maggiore realismo. Il frutto delle ricerche condotte per venti anni in quella zona dagli Italiani è raccolto nell'opera recentemente pubblicata dal dotto Fabrizio Mori (F. MORI, Tradart Acacus: arte rupestre e culture del Sahara preistorico, Einaudi, Torino 1965.)
Le pitture e le incisioni su rocce illustrano eloquentemente «la furia degli elefanti selvaggi», di Plinio; «l'arida nutrice di leoni», di Orazio; e «i carri cacciatori di uomini», di Plutarco. Non è facile convincersi che questa vasta regione di dune ondulate chiamata «il mare di sabbia» (dove si possono trovare ancora oggi resti di alberi pietrificati), era a memoria d'uomo una foresta tropicale tappezzata di erbe lussureggianti. Su sporgenze di arenaria e pareti di canyons, levigate dall'acqua che vi scorreva una volta, gli uomini che cacciavano in quei tempi remoti i grandi animali della regione hanno lasciato numerosi graffiti raffiguranti leoni, rinoceronti, elefanti e giraffe, non solo nel Uadi Acacus, ma in altre zone coperte di sabbia del Sahara Libico. La loro chiara testimonianza deve convincerci che in un periodo non inferiore a 8000 anni fa quella zona, ora desolata e invasa dalle sabbie, era coperta di foreste e ricca di fiumi e di laghi, e che i suoi pascoli lussureggianti nutrivano branchi smisurati di fiere. Più tardi, all'incirca dopo il 3500 a.C., quando disponevano già di bestiame addomesticato, quei nomadi del deserto cominciarono a illustrare anche questa fase del loro sviluppo, ritraendosi, - sulle stesse pareti dei canyons o delle caverne dove abitavano, - nelle tre loro attività principali: l'amore, la caccia e la guerra.
Per un popolo mesolitico questi graffiti rappresentano una testimonianza eccezionale, tanto più che non si tratta di figurazioni astratte come le pitture murali del periodo detto del «Cacciatore» rinvenute in altre regioni del Sahara. In quelle a tre colori della caverna dell'Uadi di Tin-n-Ascigh i loro autori si rivelano per un popolo pastorale. I loro greggi sono ritratti in riposo o mentre si spostano; alcuni portano perfino dei carichi. Degli uomini sono riprodotti mentre infilano a un altro una sorta di gabbia di vimini, per fargli rappresentare una divinità. Una donna si lava i capelli tagliati in una maniera che Erodoto descrive come l'acconciatura di una tribù libica del quinto secolo: «... li portano in forma di cresta radendoli completamente ai lati e lasciandoli crescere al centro». Figure armate, con questo tipo di acconciatura, sono mostrate mentre combattono. Un altro gruppo porta degli indumenti simili al poncho e copricapi come quelli usati dagli antichi egizi. Queste figure, - abitualmente ritratte con bestiame: buoi, capre e gazzelle, oppure mentre cacciano inseguendo di solito struzzi o giraffe - sono molto frequenti. Nei graffiti del Tradart Acacus irrompono improvvisamente carri tirati da cavalli. Come arrivarono fino al centro dell'Africa? Che cosa potevano farsene, questi uomini il cui attrezzo principale era l'ascia di pietra, di un carro con ruote a raggi, considerato finora il segno di una società molto più progredita? La ruota riprodotta in questi graffiti non è il solito disco tripartito di legno dei pesanti veicoli tirati da buoi, di cui si sa che era usato in Mesopotamia all'incirca nel 3000 a.C. Questi carri dell'età della pietra dell'Uadi Acacus libico hanno ruote a raggi e sono tirati da due e qualche volta da quattro cavalli. Allora, come adesso, per costruirne di simili un carraio doveva disporre non solo di una tecnica piuttosto progredita, ma di molta abilità. Bisognava incastrare i raggi negli appositi fori dell'asse, praticare altre cavità per la ruota e infine piegare la ruota stessa col fuoco o tagliarla con attrezzi di metallo. È stato scientificamente dimostrato che non è possibile costruire ruote con raggi senza seghe speciali per il metallo e pesanti attrezzi di ferro.
«Il carro», scrive un autorevole studioso di trasporti primitivi, «era una macchina che soltanto uno stato civilizzato poteva produrre e far funzionare ... e con cui nessun barbaro poteva competere». E tuttavia ecco un popolo preistorico che fin dal 2000 a. C., pur non conoscendo i metalli (i Libici non ebbero le età del bronzo e del ferro) costruiva e usava carri.
I Garamanti, la tribù più numerosa e turbolenta di quelle dell'interno, cominciarono a usare i metalli soltanto quando, attraverso i loro scambi commerciali, ebbero gli utensili necessari dai Fenici, dai Greci e infine dai Romani. Perfino allora continuarono a servirsi dell'accetta di pietra, e si sa che fino al terzo secolo, dopo mille e trecento anni di contatti con popoli che usavano i metalli, non abbandonarono i loro attrezzi primitivi. Come fecero dunque a costruire i carri che vediamo dipinti e incisi nelle caverne e sulle rocce di tutto il Fezzan? Fino ad oggi gli archeologi erano fermamente convinti. che il carro con le ruote fosse apparso dopo il 2000 a.C. e venisse dai paesi della Mezzaluna Fertile, dominati dalla civiltà della Mesopotamia. Apparso per la prima volta in Egitto nel 1420 a.C. - come è ricordato sulla Tomba di Thutmosis IV, - il carro con ruote a raggi si diffuse lentamente nel mondo eurasiatico arrivando in Britannia all'incirca nel 500 a. C. Era certamente usato in quel tempo in Libia e in tutto il Sahara. Gli indigeni lo avevano quando i primi invasori sbarcarono sulle coste di Tripoli «... mostrarono ai Greci», dice Erodoto, «come attaccare quattro cavalli a un carro») e sappiamo che in un periodo di tregua con i Romani di Garamanti lo usarono in una loro spedizione per rifornirsi di schiavi nella regione centrale africana del Lago Ciad.
In un suo saggio sulla ruota e in particolare sul carro, il Prof. V. Gordon Childe afferma che «cavallo e ruote a raggi sembrino indivisibili. Sarà forse un semplice caso, ma la loro prima apparizione nel bacino del Tigri-Eufrate e nei suoi dintorni si può far risalire a una data esatta. Appaiono ambedue bruscamente nella Mesopotamia come se vi fossero stati importati bell'e fatti da paesi stranieri ...». Nelio Balbo con la III Legione Augusta si decise infine a marciare contro quella tribù turbolenta. Balbo era il nipote di quel Cornelio Balbo di Cadice senza il quale Giulio Cesare non sarebbe forse riuscito a trionfare in Spagna.
Duro e implacabile come suo zio, fece percorrere perfino nel deserto alle sue legioni più di venti miglia al giorno; inseguì i Garamanti oltre Ghadames - dove occupò un avamposto - e attraversò l'altopiano pauroso di Al Hammadah fino alla loro oasi di Brak e oltre il caravanserraglio di Sebha. Nell'anno 69, sotto la guida dei Garamanti le tribù del deserto arrivarono di nuovo davanti a Leptis Magna.

Diodoro siculo
L'assedio fu spezzato soltanto dall'arrivo di coorti della III Legione Augusta comandate da Valerio Festo. Carichi di bottino i Garamanti stavano riprendendo la loro via tradizionale nel deserto quando, avendone trovata una più breve di quattro giorni (che i Romani chiamarono poi la Praeter Caput Saxi) Valerio Festo li accerchiò e dopo averli sterminati se ne tornò indietro col bottino. Sembra che più tardi, sotto Traiano, i Romani siano venuti a patti con i Garamanti. Nell'anno 100 due loro comandanti, Settimio Flacco e Giulio Materno, arrivarono in Etiopia attraversando con marce forzate in trenta giorni il deserto del Sahara e il Sudan. Aiutati dai Garamanti catturarono un gran numero di Etiopi assaltandoli con i carri a quattro cavalli dei loro alleati. I racconti di carri a quattro cavalli nel Sahara hanno lasciato increduli per secoli gli storici. Com'era possibile che questi Garamanti, un popolo neolitico che usava come strumento soltanto accette di pietra, avessero potuto costruire un congegno complicato come la ruota a sei raggi? Soltanto in epoche molto recenti gli esploratori hanno trovato nel deserto la prova che Erodoto aveva ragione. Il paleontologo francese Henri Lhothe, che in venticinque anni di esplorazioni rinvenne nei canyons del Sahara francese le pitture di Tassili, ha scoperto centinaia di disegni preistorici di carri tirati da cavalli, raffigurati quasi sempre mentre inseguono uomini o animali.
Negli affreschi dei Tassili uomini e animali sono ritratti come vivevano fra 6000 anni a. C. e i nostri tempi. Anche nel Tradart Acacus, dove, cinquecento miglia ad est, il Tropico del Cancro taglia la Libia, il Niger, il Ciad e l'Algeria, sono stati rinvenuti affreschi con gli stessi carri tirati da cavalli, ma riprodotti con maggiore realismo. Il frutto delle ricerche condotte per venti anni in quella zona dagli Italiani è raccolto nell'opera pubblicata dal dotto Fabrizio Mori (F. MORI, Tradart Acacus: arte rupestre e culture del Sahara preistorico, Einaudi, Torino 1965)
Le pitture e le incisioni su rocce illustrano eloquentemente «la furia degli elefanti selvaggi», di Plinio; «l'arida nutrice di leoni», di Orazio; e «i carri cacciatori di uomini», di Plutarco. Non è facile convincersi che questa vasta regione di dune ondulate chiamata «il mare di sabbia» (dove si possono trovare ancora oggi resti di alberi pietrificati), era a memoria d'uomo una foresta tropicale tappezzata di erbe lussureggianti. Su sporgenze di arenaria e pareti di canyons, levigate dall'acqua che vi scorreva una volta, gli uomini che cacciavano in quei tempi remoti i grandi animali della regione hanno lasciato numerosi graffiti raffiguranti leoni, rinoceronti, elefanti e giraffe, non solo nel Uadi Acacus, ma in altre zone coperte di sabbia del Sahara Libico. La loro chiara testimonianza deve convincerci che in un periodo non inferiore a 8000 anni fa quella zona, ora desolata e invasa dalle sabbie, era coperta di foreste e ricca di fiumi e di laghi, e che i suoi pascoli lussureggianti nutrivano branchi smisurati di fiere.
Più tardi, all'incirca dopo il 3500 a. C., quando disponevano già di bestiame addomesticato, quei nomadi del deserto cominciarono a illustrare anche questa fase del loro sviluppo, ritraendosi, - sulle stesse pareti dei canyons o delle caverne dove abitavano, - nelle tre loro attività principali: l'amore, la caccia e la guerra. Per un popolo mesolitico questi graffiti rappresentano una testimonianza eccezionale, tanto più che non si tratta di figurazioni astratte come le pitture murali del periodo detto del «Cacciatore» rinvenute in altre regioni del Sahara. In quelle a tre colori della caverna dell'Uadi di Tin-n-Ascigh i loro autori si rivelano per un popolo pastorale. I loro greggi sono ritratti in riposo o mentre si spostano; alcuni portano perfino dei carichi. Degli uomini sono riprodotti mentre infilano a un altro una sorta di gabbia di vimini, per fargli rappresentare una divinità. Una donna si lava i capelli tagliati in una maniera che Erodoto descrive come l'acconciatura di una tribù libica del quinto secolo: «... li portano in forma di cresta radendoli completamente ai lati e lasciandoli crescere al centro». Figure armate, con questo tipo di acconciatura, sono mostrate mentre combattono. Un altro gruppo porta degli indumenti simili al poncho e copricapi come quelli usati dagli antichi egizi. Queste figure, - abitualmente ritratte con bestiame: buoi, capre e gazzelle, oppure mentre cacciano inseguendo di solito struzzi o giraffe - sono molto frequenti.
Nei graffiti del Tradart Acacus irrompono improvvisamente carri tirati da cavalli. Come arrivarono fino al centro dell'Africa? Che cosa potevano farsene, questi uomini il cui attrezzo principale era l'ascia di pietra, di un carro con ruote a raggi, considerato finora il segno di una società molto più progredita? La ruota riprodotta in questi graffiti non è il solito disco tripartito di legno dei pesanti veicoli tirati da buoi, di cui si sa che era usato in Mesopotamia all'incirca nel 3000 a.C. Questi carri dell'età della pietra dell'Uadi Acacus libico hanno ruote a raggi e sono tirati da due e qualche volta da quattro cavalli. Allora, come adesso, per costruirne di simili un carraio doveva disporre non solo di una tecnica piuttosto progredita, ma di molta abilità. Bisognava incastrare i raggi negli appositi fori dell'asse, praticare altre cavità per la ruota e infine piegare la ruota stessa col fuoco o tagliarla con attrezzi di metallo. È stato scientificamente dimostrato che non è possibile costruire ruote con raggi senza seghe speciali per il metallo e pesanti attrezzi di ferro. «Il carro», scrive un autorevole studioso di trasporti primitivi, «era una macchina che soltanto uno stato civilizzato poteva produrre e far funzionare ... e con cui nessun barbaro poteva competere». E tuttavia ecco un popolo preistorico che fin dal 2000 a. C., pur non conoscendo i metalli (i Libici non ebbero le età del bronzo e del ferro) costruiva e usava carri. I Garamanti, la tribù più numerosa e turbolenta di quelle dell'interno, cominciarono a usare i metalli soltanto quando, attraverso i loro scambi commerciali, ebbero gli utensili necessari dai Fenici, dai Greci e infine dai Romani. Perfino allora continuarono a servirsi dell'accetta di pietra, e si sa che fino al terzo secolo, dopo mille e trecento anni di contatti con popoli che usavano i metalli, non abbandonarono i loro attrezzi primitivi.
Come fecero dunque a costruire i carri che vediamo dipinti e incisi nelle caverne e sulle rocce di tutto il Fezzan? Fino ad oggi gli archeologi erano fermamente convinti. che il carro con le ruote fosse apparso dopo il 2000 a. C. e venisse dai paesi della Mezzaluna Fertile, dominati dalla civiltà della Mesopotamia. Apparso per la prima volta in Egitto nel 1420 a. C. - come è ricordato sulla Tomba di Thutmosis IV, - il carro con ruote a raggi si diffuse lentamente nel mondo eurasiatico arrivando in Britannia all'incirca nel 500 a. C. Era certamente usato in quel tempo in Libia e in tutto il Sahara. Gli indigeni lo avevano quando i primi invasori sbarcarono sulle coste di Tripoli «... mostrarono ai Greci», dice Erodoto, «come attaccare quattro cavalli a un carro») e sappiamo che in un periodo di tregua con i Romani di Garamanti lo usarono in una loro spedizione per rifornirsi di schiavi nella regione centrale africana del lago Ciad.
In un suo saggio sulla ruota e in particolare sul carro, il Prof. V. Gordon Childe afferma che «cavallo e ruote a raggi sembrino indivisibili. Sarà forse un semplice caso, ma la loro prima apparizione nel bacino del Tigri-Eufrate e nei suoi dintorni si può far risalire a una data esatta. Appaiono ambedue bruscamente nella Mesopotamia come se vi fossero stati importati bell'e fatti da paesi stranieri ...».