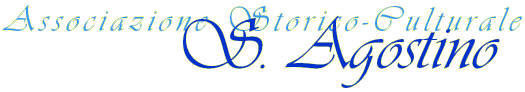Contenuto
Percorso : HOME > Iconografia > Cicli > Seicento > Miguel de SantiagoCICLo AGOSTINIANo di Miguel de Santiago a QUITO

Agostino e san Bonaventura
MIGUEL DE SANTIAGO
1656
Monastero agostiniano di Quito
Agostino e san Bonaventura
La scena non Ŕ ben conservata e di difficile lettura e interpretazione. Sulla destra si vedono due vescovi di diverse dimensioni, uno pi¨ giovane e piccolo con la barba bianca e un altro pi¨ grande dalla barba nera. Entrambi indossano delle tuniche scure e volgono lo sguardo verso il basso dove Ŕ inginocchiato un monaco con una tunica scura, che allunga le mani verso il vescovo pi¨ piccolo, che gli para davanti.
La didascalia nel margine inferiore ci specifica che la scena riguarda la figura di san Bonaventura in un incontro ideale con Agostino. L'episodio tende probabilmente ad esaltare l'affinitÓ delle speculazioni e del pensiero teologico fra i due santi.
Nel secolo XIII in effetti l'agostinismo fu posto in antitesi all'aristotelismo di Tommaso. Seguendo la linea di pensiero di sant'Agostino si rimprover˛ ad Aristotele l'eternitÓ del mondo, inconciliabile con il concetto biblico di creazione, e il riconoscimento di Dio solo come causa finale, e non come entitÓ a sÚ. Bonaventura da Bagnoregio (circa 1217-1274), importante esponente della scuola francescana si trov˛ a svolgere un ruolo di primo piano in questa polemica. Bonaventura aveva studiato all'universitÓ di Parigi sotto la guida di Alessandro di Hales e nel 1248 aveva iniziato a dedicarsi all'insegnamento intervenendo contro il dilagante averroismo. Dedic˛ gli ultimi anni della sua vita alla preparazione del concilio di Lione del 1274, che aveva l'obiettivo di promuovere l'unione con le Chiese ortodosse. Il suo pensiero Ŕ caratterizzato da una profonda struttura unitaria, dove filosofia, teologia e mistica si trovano fuse sistematicamente. Riprendendo tematiche filosofiche e teologiche di Agostino e Anselmo d'Aosta, Bonaventura svilupp˛ la sua dottrina nel solco della tradizione neoplatonica cristiana. Il suo pensiero Ŕ in linea con quello agostiniano, con una forte accentuazione spirituale a mistica.
Secondo la sua visione la veritÓ verrebbe raggiunta passando dal riconoscimento che i limiti del sapere umano possono essere superati solo dalla accettazione di un cammino della mente che si lasci illuminare dalla fede e dalla rivelazione.
La sua speculazione pertanto fu interamente votata alla ricerca costante di Dio, dove il viaggio mistico porta a pienezza "l'itinerario della mente in Dio", che Ŕ reso possibile soltanto dall'originaria presenza illuminante di Dio nella stessa anima dell'uomo.
Questo “Itinerarium mentis in Deum” (titolo della sua opera pi¨ celebre del 1259) partendo dalla riflessione pi¨ esteriore, pu˛ giungere a compimento solo se, passando attraverso quella dimensione interiore che giÓ Agostino aveva esaltato, arriva a farsi illuminare dalla Rivelazione, che ci introduce a Dio e alla sua VeritÓ. Per Bonaventura il sapere Ŕ soprattutto contemplazione, accostamento mistico a Dio. L'illuminazione che noi riceviamo ci permetterÓ di portare al compimento pratico del bene. San Bonaventura Ŕ all'origine della cultura dei pensatori francescani: sia i suoi testi che quelli di Agostino, anche se non sempre di agevole lettura, stanno tra quelli che hanno costruito la cultura europea.