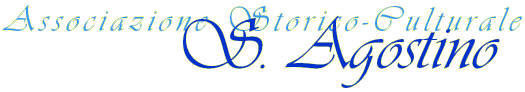Contenuto
Percorso : HOME > Iconografia > Cicli > Seicento > Miguel de SantiagoCICLo AGOSTINIANo di Miguel de Santiago a QUITO

Agostino e san Tommaso
MIGUEL DE SANTIAGO
1656
Monastero agostiniano di Quito
Agostino e san Tommaso
La scena dipinta da Miguel de Santiago pone di fronte l'uno all'altro Agostino e Tommaso d'Aquino. I due si stringono la mano in segno di amicizia e di condivisione. Entrambi hanno il capo circondato da una flebile aureola bianca che contrassegna simbolicamente i santi. Agostino è ritto in piedi a sinistra e indossa la tunica nera dei monaci che seguono la sua regola. Sul petto pende una collana con un crocifisso mentre con la mano sinistra regge un voluminoso libro che reca sulla copertine l'immagine di un cuore ardente.
Il volto del santo ha un aspetto ancora giovanile con una barba scura ben curata e uno sguardo acuto e penetrante. Tra i due si distende un cartiglio che riporta VERUM VERO CONSONNI. Alle spalle di Agostino, appoggiata alla colonna, si intravede il lungo ed esile bastone pastorale, mentre sul ripiano dove poggia lo colonna è stata riposta la mitra del santo.
Tommaso, dalla corporatura più robusta, ha anch'egli un viso giovanile e cordiale con un debole accenno alla barba che gli copre le gote. Era un frate domenicano, principale esponente della Scolastica, e veniva definito Doctor Angelicus già dai suoi contemporanei.
I domenicani seguivano una regola che si ispirava a quella di Agostino e il suo fondatore Domenico aveva frequentato da giovane un monastero agostiniano. Secondo l'iconografia del santo, Tommaso è raffigurato come un uomo piuttosto corpulento, con indosso l'abito dell'ordine domenicano. Due sono i simboli in particolare che lo caratterizzano: il sole raggiato sul petto e il libro che tiene in mano. Li ritroviamo entrambi nel dipinto di Santiago. In questo caso l'autore ha aggiunto un giglio che tradizionalmente significa esprimere purezza e castità, nobiltà e fierezza d'animo, innocenza e candore.
Tommaso nacque a Roccasecca presso Aquino nel 1225 dai nobili Landolfo di origine longobarda e Teodora di origini normanne. Fu destinato alla vita monastica nell'abbazia di Montecassino, dove vestì l'abito benedettino a cinque anni. Avendo conosciuto l'Ordine Domenicano (di regola agostiniana) decise di entrarvi nel 1243-1244. Fu mandato dai superiori a Roma, contraria la madre, che fece di tutto per opporsi. Proseguì gli studi a Colonia con Alberto Magno, divenendone discepolo. Ben presto si rivelò dotato di ingegno finissimo diventando un grande teologo e dottore della Chiesa.
San Tommaso fu uno dei pensatori più eminenti della filosofia Scolastica, che verso la metà del XIII secolo aveva raggiunto il suo apogeo. Egli indirizzò diversi aspetti della filosofia del tempo: la questione del rapporto tra fede e ragione, le tesi sull'anima (in contrapposizione ad Averroè), le questioni sull'autorità della religione e della teologia, che subordina ogni campo della conoscenza. Tali punti fermi del suo pensiero furono difesi da diversi suoi seguaci successivi, tra cui Reginaldo di Piperno, Tolomeo da Lucca, Giovanni di Napoli, il domenicano francese Giovanni Capreolus e Antonino di Firenze.
Agostino vedeva il rapporto fede-ragione come un circolo ermeneutico (dal greco ermeneuo, cioè "interpreto") in cui credo ut intelligam et intelligo ut credam (ossia "credo per comprendere e comprendo per credere"). Tommaso porta la fede su un piano superiore alla ragione, affermando che dove la ragione e la filosofia non possono proseguire inizia il campo della fede ed il lavoro della teologia. Dunque, fede e ragione sono certamente in circolo ermeneutico e crescono insieme sia in filosofia che in teologia. Mentre però la filosofia parte da dati dell'esperienza sensibile o razionale, la teologia inizia il circolo con i dati della fede, su cui ragiona per credere con maggiore consapevolezza ai misteri rivelati. La ragione, ammettendo di non poterli dimostrare, riconosce che essi, pur essendo al di sopra di sé, non sono mai assurdi o contro la ragione stessa: fede e ragione, sono entrambe dono di Dio, e non possono contraddirsi.